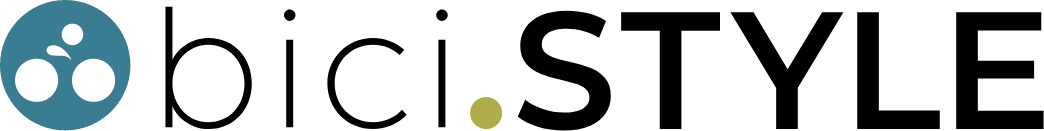La scalata di un 8.000, una maratona, il record dell’Ora: cosa hanno in comune? Beh, oltre al gusto dell’impresa, la durezza della parte finale. Si dice che nella maratona dopo il 35°, ogni chilometro valga per tre. Che 100 metri di dislivello al di sopra degli 8.000 metri vadano moltiplicati per quattro. E lo stesso vale per i 10 minuti finali del record dell’Ora, una specialità tanto affascinate quanto dolorosa.
Ed è un po’ quel che mercoledì scorso è successo all’inglese Alex Dowsett. E’ stato più o meno sui tempi di Victor Campenaerts, poi è crollato, fermandosi a poco più di mezzo chilometro dal primatista belga: 534 metri per la precisione.


Parola a Morelli
Ma cosa succede in quell’ora al corpo umano? E ancora meglio, cosa succede in quei 10′-15′ finali? Proviamo a fare chiarezza con Andrea Morelli, del Centro Mapei Sport, il quale entra subito nel merito.
«E’ un discorso molto ampio – dice Morelli – Io parlerei prima di tutto di fatica metabolica, che in quella fase finale è legata principalmente ad un discorso energetico, al quale si associa anche una fatica psicologica.
«Quando tenti il record dell’Ora cerchi di ottimizzare la potenza nell’arco dei 60’. Pertanto lavori molto sulla potenza aerobica, cerchi di aumentarla il più possibile. Se il VO2 Max, cioè il massimo consumo d’ossigeno, può durare all’incirca 7′, la soglia la si dovrebbe tenere per 40′-60′. Il problema qual è? E’ che il corpo è in equilibrio tra produzione e smaltimento di acido lattico. Spingendo forte in modo costante e supponendo di essere al limite, a un certo punto questo equilibrio si rompe e si inizia ad accumulare acido lattico. Di conseguenza la prestazione inizia a calare».


Tabella di marcia
«Tu imposti la tua tabella di marcia – riprende Morelli – sai che ad ogni giro dovrai mantenere un certo tempo, tuttavia partendo da fermi si inizia subito con un deficit. Proprio alla partenza inizia l’accumulo che ci si porta dietro per tutta la durata del tentativo. Anche se in fase di avvio non si è “a tutta”, si passa da uno stato di metabolismo basale ad uno cinetico, di sforzo. Questo fa sì che si produca subito un debito energetico che solitamente si paga nel finale. E per questo è molto importante essere graduali al via».
In pratica bisogna arrivare a regime quanto prima, ma senza accumulare acido lattico o limitarlo al massimo, anche se muscolarmente in quel momento l’atleta non avverte nulla, non ha la sensazione di mal di gambe. Il rovescio della medaglia è che ad essere troppo cauti, si rischia di perdere troppo terreno.


Disaccoppiamento Fc/Watt
Il discorso sulla partenza da fermo innesca poi un tema affatto secondario: il disaccoppiamento tra la frequenza cardiaca e la potenza espressa, i watt. Che poi il gioco è tutto lì. Perché la letteratura scientifica è una cosa e la realtà è un’altra.
«Prima – dice Morelli – abbiamo detto che in teoria un atleta può tenere il ritmo di soglia anche per 60′. Cioè per un’ora c’è equilibrio fra l’acido lattico prodotto e quello smaltito. Un equilibrio che alla soglia viene individuato in 4 millimoli di acido lattico. In realtà questo valore è un po’ più basso. O quantomeno non dura per 60′. A un certo punto infatti, vuoi perché aumenta la temperatura corporea, vuoi perché cala il glicogeno nei muscoli, il cuore per mantenere lo stesso livello di potenza aumenta i battiti. In questo modo però, poco dopo aumentano anche le 4 millimoli di acido lattico prodotte e il corpo non può smaltirne di più». E a lungo andare la prestazione decade.


Equilibrio molto sottile
Durante il tentativo di record non ci si può alimentare, né bere. Ogni scorta pertanto deve essere fatta prima del via e deve essere ben valutata.
«La strategia è fondamentale – spiega Morelli – vengono ad innescarsi due meccanismi di fatica: quella periferica e quella centrale. La prima, semplificando al massimo, è il mal di gambe. Ed è la capacità di esprimere la forza nell’arco del tempo. La seconda riguarda il massimo consumo di ossigeno e va ad intaccare il sistema cognitivo e nervoso. Anche il cervello si stanca e ha una determinata percezione della fatica.
«Detto ciò, è molto importante riuscire a trovare il proprio passo su quel determinato dispendio energetico. Nella fatica subentrano tantissimi meccanismi. Il corpo umano trae energia dal fegato, da una parte interna all’organismo che c’è in circolo (ma è molto piccola) e dal glicogeno: è importante riuscire a sfruttarle al massimo e al meglio».


Aerodinamica o ossigenazione?
In velodromo poi le variabili sono meno, ma possono diventare più complicate: come per esempio la termoregolazione. E questo, non potendo bere né gettarsi acqua addosso come si vede spesso fare d’estate, incide più di quanto si possa pensare sulla prestazione e sui minuti finali, come è intuibile.
«L’atleta a un certo punto raggiunge una temperatura interna critica e molti meccanismi entrano in crisi. E lo fanno tutti insieme. Quali? La temperatura troppo alta appunto, l’acido lattico nei muscoli, la scarsità di carboidrati per i muscoli, la diminuzione della forza periferica… Tutto ciò mette in crisi prima di tutto il cervello che è la centralina che comanda tutto.
«Inoltre, nel caso di Dowsett, non dimentichiamo che era in quota (quasi 1.900 metri, ndr). E per i grossi motori aerobici come il suo, paradossalmente è peggio. Poi chiaramente va valutato il punto di equilibrio fra la potenza aerodinamica (che con l’aria rarefatta aumenta) e quella aerobica, che appunto diminuisce. Questo però non toglie il fatto che il cervello, con minor ossigeno a disposizione, sia chiamato ad un extralavoro».
«Chi affronta il Record dell’Ora – conclude Morelli – deve avere caratteristiche molto particolari, fisiche ma anche psicologiche. Deve essere in grado di soffrire moltissimo. Non a caso, quando concludono la prova non stanno in piedi. E questo è anche il motivo per cui in allenamento, quando raggiungono i livelli di potenza aerobica che intendono mantenere, non fanno mai sessioni complete di un’ora, ma di 20′-25′, al massimo 30′. Altrimenti sapendo cosa li aspetta, sarebbero già battuti in partenza».