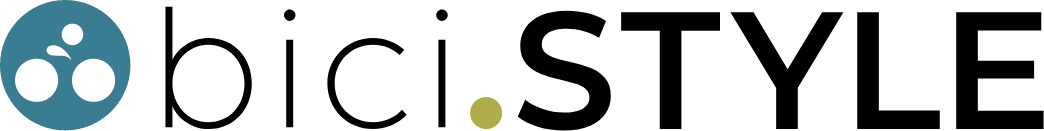Nei giorni scorsi Garmin Italia ha presentato ufficialmente l’edizione 2022 dei “Garmin Beat Yesterday Awards”, i riconoscimenti che premiano l’impegno nella realizzazione delle proprie imprese sportive. Nati nel 2016, nell’arco di sei edizioni hanno premiato ben 45 progetti, gli ultimi dei quali in occasione di una bellissima serata che si è svolta a Milano nel mese di dicembre dello scorso anno presso la prestigiosa location di Spazio Gessi.


Al via con le candidature
A partire dallo scorso 2 maggio fino al 16 settembre sarà possibile inviare la propria candidatura compilando il modulo disponibile al seguente link: https://www.garmin.com/it-IT/forms/beatyesterday/.
Una giuria interna a Garmin Italia visionerà e valuterà le proposte ricevute così da selezionare, e dunque premiare, i progetti più interessanti e in linea con i valori dei “Beat Yesterday”. L’obiettivo di Garmin Italia è infatti quello di valorizzare un progetto di persone ordinarie che compiono qualcosa di straordinario, dedicando tempo ed energie per riuscire in un’impresa tutta personale che il resto del mondo definisce impossibile.
Ricordiamo infatti che per partecipare non è necessario possedere particolari caratteristiche o doti sportive. Chiunque può presentare la propria avventura. Nessun limite creativo al progetto, nessun vincolo alla disciplina, nessun obbligo di un format da adottare a tutti i costi. Viene lasciato ampio spazio all’originalità, alla singolarità ma soprattutto alla autenticità. L’invito che arriva da Garmin è uno solo: migliòrati!
Orgoglio Garmin
Stefano Viganò, Amministratore Delegato di Garmin Italia, è da sempre un convito sostenitore dei “Garmin Beat Yesterday Awards”.
«Siamo davvero molto orgogliosi di tornare ad affiancare chi ha grandi sogni nel cassetto – racconta – con i nostri Beat Yesterday Awards vogliamo contribuire alla loro realizzazione, perché una sfida è tale se richiede quella dedizione che porta a superare un limite. In questo assunto, lo spirito che anima il premio coincide con la storia e i valori della nostra azienda: desiderio continuo di miglioramento, sfida con sé stessi e realizzazione di qualcosa che fino a quel momento si era ritenuto impossibile».


L’ispirazione di Baldini
Ispiratore e tutor del progetto Beat Yesterday è Stefano Baldini (foto apertura Garmin_Beat Yesterday Award). Il protagonista dell’indimenticabile vittoria nella maratona alle Olimpiadi di Atene 2004 è oggi un riferimento assoluto per generazioni di podisti. Ricordando la sua vittoria a cinque cerchi ha voluto indirettamente lanciare un messaggio a quanti vorranno inviare la propria candidatura per l’edizione 2022 dei “Garmin Beat Yesterday Awards”.
«Ricordo perfettamente quel giorno. L’ingresso allo stadio, illuminato a giorno e pieno di gente, è stato un momento impagabile. Uno schiaffo che mi ha tolto tutta la concentrazione. Sul mio viso lo stupore per quello che stava accadendo. Mi sono stupito di me stesso: avevo avuto la mia grande occasione e non l’avevo sprecata, ero riuscito a superare i miei limiti nella gara più importante. Ognuno di noi può avere davanti a sé l’occasione per battere sé stessi».